|
|
|
IL FUTURISMO |
Storia dell’arte |
Ø LA PITTURA:
Il futurismo italiano come manifestazione
artistico-culturale copre un periodo molto vasto che inizia nel1909 e si
conclude, nella sua prima fase, definita eroica, nel 1918. Un secondo periodo
parte dal dopoguerra e si protrae fino agli anni quaranta. Nei primi anni il
movimento si batte per l’affermazione dei propri ideali espressi nel Manifesto apparso su “Le
Figaro” nel 1909, firmato da Filippo Tommaso  Martinetti. La pittura è la prima che scende in campo: il Manifesto
dei pittori futuristi, esce l’11 febbraio 1910, firmato dai cinque
rappresentanti del movimento: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà,
Luigi Russolo e Gino Severini. Balla è un pittore postimpressionista e
simbolista; Boccioni segue uno stile vario ed eclettico; Carrà si rivolge al
realismo ottocentesco lombardo assieme a Severini e Russolo. Soltanto a partire dal 1910 si cominciano a vedere
opere realizzate secondo le nuove idee futuriste, come la
Martinetti. La pittura è la prima che scende in campo: il Manifesto
dei pittori futuristi, esce l’11 febbraio 1910, firmato dai cinque
rappresentanti del movimento: Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà,
Luigi Russolo e Gino Severini. Balla è un pittore postimpressionista e
simbolista; Boccioni segue uno stile vario ed eclettico; Carrà si rivolge al
realismo ottocentesco lombardo assieme a Severini e Russolo. Soltanto a partire dal 1910 si cominciano a vedere
opere realizzate secondo le nuove idee futuriste, come la  Rissa in galleria di
Boccioni, in cui si trovano espresse graficamente quelle caratteristiche del
movimento sintetizzate nella frase che conclude il Manifesto: «Noi vogliamo […]
rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente, tumultuosamente
trasformata dalla scienza vittoriosa».
Rissa in galleria di
Boccioni, in cui si trovano espresse graficamente quelle caratteristiche del
movimento sintetizzate nella frase che conclude il Manifesto: «Noi vogliamo […]
rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente, tumultuosamente
trasformata dalla scienza vittoriosa».
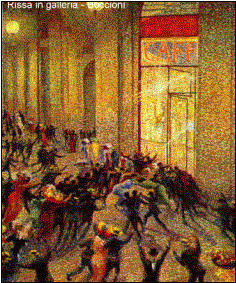 In tutti i campi si è aperta una nuova realtà. I miti
ottocenteschi devono essere distrutti senza pietà e i futuristi scelgono di
coinvolgere attivamente il pubblico nella lotta, per mezzo di polemici
manifesti e conferenze provocatorie. Oltre che dalle conquiste tecniche e
scientifiche i futuristi sono colpiti dalla nuova
In tutti i campi si è aperta una nuova realtà. I miti
ottocenteschi devono essere distrutti senza pietà e i futuristi scelgono di
coinvolgere attivamente il pubblico nella lotta, per mezzo di polemici
manifesti e conferenze provocatorie. Oltre che dalle conquiste tecniche e
scientifiche i futuristi sono colpiti dalla nuova 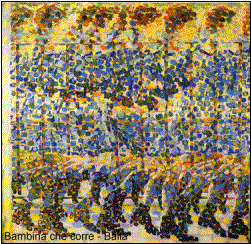 realtà sociale che si sta sviluppando. Milano offre molte
opportunità con la sua periferia industriale, le case operaie, le ciminiere:
tutti soggetti spesso ritratti da Boccioni in quadri come Il rumore della
realtà sociale che si sta sviluppando. Milano offre molte
opportunità con la sua periferia industriale, le case operaie, le ciminiere:
tutti soggetti spesso ritratti da Boccioni in quadri come Il rumore della 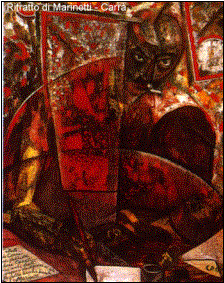 strada entra in casa.
strada entra in casa.
Dinamismo e simultaneità sono i caratteri principali del
futurismo, intesi non solo in senso tecnologico, ma anche psicologico: l’uomo
deve essere raffigurato non più immobile e frontale, ma secondo tutta la
successione dei suoi moti sia interiori che esteriori. La simultaneità, in
questo senso, viene perfettamente espressa da Balla nei dipinti Bambina che
corre sul bancone e Dinamismo per un cane al guinzaglio. Anche Carrà
rende bene questo concetto della simultaneità dei moti del corpo e dell’animo
unita al dinamismo e al divisionismo nel quadro I funerali dell’anarchico
Galli. Gino Severini riesce invece a creare emozioni particolari nello
spettatore, il quale oltre che dai colori e dagli eleganti  arabeschi, viene attratto dalla sua capacità di bloccare
le immagini come fossero istantanee
scomposte e ricomposte una vicino all’altra.
arabeschi, viene attratto dalla sua capacità di bloccare
le immagini come fossero istantanee
scomposte e ricomposte una vicino all’altra.
