|
|
|
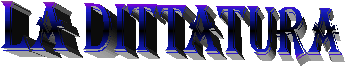
|
C |
on il discorso del 3 gennaio 1925 si apriva una nuova fase nella storia nazionale: il fascismo si presentò come una dittatura repressiva. Vennero limitate le libertà di stampa e di associazione, poi il governo si rafforzò con numerosi strumenti: la possibilità di promulgare decreti e norme con validità immediata e l’accentramento di funzioni prima appartenenti ai comuni. Fu creato un tribunale speciale per giudicare i delitti contro lo Stato (1926) e fu prevista la revoca della cittadinanza per i nemici dello Stato (ovvero del fascismo) e il sequestro dei loro beni. Questi provvedimenti presero il nome di «leggi fascistissime».
Il 4 novembre 1925 fu scoperto un complotto per
uccidere Mussolini organizzato dall’onorevole socialista Tito Zaniboni e dal
generale e senatore Gaetano Giardino e fu usato come pretesto per restringere
ulteriormente le libertà.
Nel 1926 fu istituito in tutti i comuni il
sistema podestarile: i sindaci elettivi venivano sostituiti da podestà a carica
quindicinale nominati dal prefetto in accordo con le autorità locali del
partito. I podestà assumevano tutti i poteri del sindaco, della giunta e del
consiglio comunale.
Venne abolita la segretezza del voto e ciò fu la
causa dei risultati delle elezioni del 1929:
8 milioni e mezzo di consensi contro 135.761 oppositori. A ogni modo gli
storici sono concordi nel dire che anche in presenza di un’opposizione e di una
maggiore libertà di voto il fascismo avrebbe stravinto. Mussolini infatti aveva
meticolosamente curato i rapporti con la Chiesa, le forze armate ed economiche,
poteri indispensabili a garantire la saldezza del suo: la grande e piccola
burocrazia pubblica e privata, l’esercito, gran parte dei cattolici aderirono
al fascismo dandogli forza, ma togliendogli al contempo molto slancio
innovatore. Sarà questa adesione solo formale una delle cause della crisi del
regime di quasi vent’anni dopo.
Il regime però godeva anche di prestigio
all’estero, gli scioperi erano finiti, l’economia migliorata, la disoccupazione
calata. Non era migliorata invece la situazione di operai e contadini, i quali
preoccupati di salvare il salvabile più che di organizzare una tenace
opposizione e rassegnati dalla vittoria del fascismo, erano orientati più che
altro a non perdere ciò che avevano potuto salvare e a non perdere quei
benefici normativi che la politica “sociale” del regime gli aveva dato.
|
L |
a
prima importante decisione economica fu presa da Mussolini a Pesaro, nel 1926,
quando, durante il suo discorso, ordinò una politica di deflazione della lira.
L’operazione venne attuata dal ministro delle finanze Giuseppe volpi (l’ordine
di Mussolini era di portare la lira a «quota novanta», ovvero far sì che una
sterlina corrispondesse a novanta lite). La lira fu rivalutata, favorendo le
aziende elettriche, importatrici di capitali e, in genere, le aziende
importatrici di capitali; d’altro canto però danneggiò le altre industrie, le
banche che le finanziavano, le esportazioni e gli imprenditori agricoli.
Mussolini cercò di contrastare il fenomeno, non riuscendo a fare però niente di
meglio che una imponente serie di lavori pubblici e la «battaglia del
grano». Uno dei provvedimenti più
importanti, però fu la «bonifica integrale»: egli voleva recuperare quelle zone
dell’Italia non ancora in condizioni dei essere sfruttate, come le paludi
pontine. Nonostante i lavori pubblici, le condizioni dei ceti popolari nel 1929
erano peggiorate: essi cominciarono a riversarsi nelle città dalle campagne,
spingendo il fascismo ad irrigidire le già esistenti leggi contro la migrazione
interna e ad esaltare la vita campestre e rurale. L’obbiettivo del ruralismo
era quello di controllare strettamente la mobilità sociale. Tale politica però
fallì miseramente, facendo riversare in città masse di contadini, inasprendo i
rapporti tra classi sociali e sfatando così uno dei miti della retorica fascista: il superamento dei
conflitti di classe in una sintesi superiore basata sul corporativismo.
La teoria corporativa fece il suo ingresso nei
programmi fascisti nel 1921. Il corporativismo si proponeva di superare i
conflitti tra lavoro e capitale mediante l’azione conciliatrice dello stato. Le
corporazioni rappresentavano sia i lavoratori sia i datori di lavoro; avrebbero
dovuto autoregolarsi con statuti e organi creati appositamente, anche se in
realtà ricevettero sempre ordini dall’alto.
Tale progetto si può far cominciare nel 1925 con
il patto di Palazzo Vidoni, con cui gli industriali riconoscevano i sindacati
fascisti come unici rappresentanti dei lavoratori; l’anno successivo fu abolito
il diritto di sciopero e di serrata. Nel 1926 vennero istituite le
Confederazioni parallele di lavoratori e datori di lavoro, gettando le basi per
lo stato corporativo. Dato lo scarso interesse di Mussolini per il
corporativismo, il principale teorico e
artefice fu Giuseppe Bottai, principale autore della Carta del lavoro, in cui
il lavoro veniva definito come dovere sociale e in cui si sostenevano i diritti
dei lavoratori su orari e festività, ferie, indennità per licenziamento o
morte, divieto di licenziamenti per malattia, periodo di prova, lavoro a
domicilio. All’idea di Bottai, però, convinto che le corporazioni dovessero
godere di ampie autonomie, prevalse quella di Rocco , secondo il quale le
corporazioni dovevano essere rigidamente assoggettate allo Stato. L’esito
finale del corporativismo, comunque, fu quello di favorire il capitale e
rafforzare la religione laica, ovvero la fascistizzazione delle masse: il
regime era penetrato nella vita del popolo tramite il suo elemento principale,
il lavoro.
Nel 1931 venne creato l’IMI, con il compito di
accordare prestiti ad aziende private in difficoltà. Nel 1932 venne fondato, per risollevare le sorti
del paese, l’IRI, che aveva la funzione di risanare le imprese private
acquistandone una compartecipazione. Tuttavia la crisi persistette, specie per
il fatto che il governo non seppe imporsi agli imprenditori.
Bisogna però dire che il regime prese alcune
importanti iniziative: il blocco biennale del prezzo degli affitti, della luce,
dell’acqua, del gas e dei trasporti; poi la progressiva riduzione degli orari
di lavoro fino alla soglia delle 40 ore. Nel 1933 venne ristrutturato l’INPS,
diretto da Bottai dopo la sua sostituzione nelle corporazioni; creò il primo
nucleo del sistema pensionistico e un apparato di controllo delle malattie
professionali e degli incidenti sul lavoro.
|
L |
’accordo fascismo-Vaticano non è così strano come potrebbe sembrare: la Chiesa aveva in comune con il fascismo tutti i nemici, condivideva con esso il bisogno di ordine, disciplina e gerarchia. La mossa che costituì un enorme vantaggio per il Vaticano e un successo per Mussolini fu il Concordato del 1929. Le principali richieste della Chiesa erano l’assoluta sovranità dello Stato pontificio e l’abrogazione delle Guarentigie. I Patti vennero firmati l’11 febbraio 1929 nel palazzo del Laterano: erano una serie di accordi che comprendeva un trattato per chiudere il problema del riconoscimento fra Stato italiano e Stato del Vaticano, la relativa convenzione finanziaria e il concordato vero e proprio. Il primo articolo dichiarava la religione cattolica come religione di Stato. L’Italia riconosceva l’esistenza e la piena indipendenza dello Stato pontificio, che a sua volta riconosceva il Regno d’Italia. Quanto alla convenzione economica al Vaticano furono dati un miliardo e settecentocinquanta milioni di lire, oltre ad una serie di vantaggi fiscali che si rivelarono ben più onerosi. Anche il duce ottenne però un vantaggio enorme dal pontefice: veniva investito di un alone sacro e sovrannaturale, sancendo il passaggio da culto del fascismo a culto di Mussolini.
Nonostante la sua apparente disponibilità e
benevolenza nei confronti della Santa Sede il duce non voleva rinunciare ad avere il monopolio delle associazioni
giovanili, negatogli con il Concordato. Così dopo una serie di scontri verbali
Pio XI si pronunciò in questo modo:«Il fascismo si dice e vuol essere
cattolico: orbene, per essere cattolici non solo di nome ma anche di fatto, e
non cattolici di falso nome […] non c’è che un mezzo: ubbidire alla Chiesa e al
Suo Capo […]». Per Mussolini era troppo. Il 29 maggio del 1931 ordinò ai prefetti
di sciogliere la FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e tutti i
circoli giovanili che non facessero parte dell’ONB (Opera Nazionale Balilla).
Il papa alla fine di luglio pubblicò l’enciclica “Non abbiamo bisogno”, in cui
riconosceva i benefici ricevuti dal fascismo, ma riaffermava che non avrebbe
ceduto l’educazione dei giovani a vantaggio di un partito che si risolveva in
una “statolatria pagana”. La situazione venne risolta con un compromesso per
cui le varie associazioni cattoliche sarebbero state decentrate e la bandiera
dell’Azione cattolica sarebbe stata il tricolore.
In apparenza Mussolini aveva vinto, ma in realtà
non riuscì a controllare l’Azione cattolica, nonostante il decentramento. La
pace definitiva venne suggellata l’11 febbraio 1932 quando il papa insignì
Mussolini dello Speron d’oro, la massima onorificenza civile del Vaticano. Da
quella data fascismo e Vaticano proseguirono felicemente insieme per tutti gli
anni della pienezza del regime.
|
F |
ino
al 1932 la politica estera fascista fu essenzialmente pacifica, anche se
Mussolini le dedicò sempre un’attenzione particolare. In essa il duce cercò dei
successi e dei diversivi per puntellare il prestigio del fascismo nel Paese.
Sfortunatamente per lui, però, Mussolini era più un capofazione che uno
statista, e molti storici sono concordi nel dire che la politica estera fu il
tallone d’Achille del regime. Fino al 1932-35 il duce seguì una politica
pacifica perché non credeva che l’Europa, né l’Italia fossero pronte ad entrare
in guerra, ma la possibilità di questa fu sempre nei suoi pensieri e nella sua
attesa si sforzò di far sì che i rapporti internazionali tra le altre nazioni
non divenissero mai troppo stabili e consolidati. Il duce volle far capire fin
da subito, però, che l’Italia fascista sarebbe stata dinamica, in concorrenza
con la Francia nella regione danubiano-balcanica e con la Gran Bretagna nel
Mediterraneo, rinominato con Mare Nostrum.
Mussolini aveva un piano semplice e preciso, ma
altrettanto pericoloso: mantenere l’Europa in tensione, eccitare le ostilità
fra Stati per poter poi trarre vantaggio dai litigi altrui.
Gli atteggiamenti del duce erano anche stimolati
dalla necessità propagandistica della politica interna; la grinta dura nei
rapporti internazionali piaceva a un popolo «che aveva sempre sofferto di
complessi di inferiorità internazionale» (G.B. Guerri). Mussolini fu
indubbiamente abile nel dare agli italiani l’impressione di contare qualcosa.
Il duce, nel 1922, fu prima a Losanna, poi a Londra per discutere i trattati di
pace.
La sua pericolosità esplose tra l’agosto e il
settembre del 1923, dopo l’uccisione del generale E. Tellini, in missione
internazionale a Corfù. Il governo greco non aveva responsabilità, ma Mussolini
avanzò richieste inaccettabili, che infatti furono respinte. Ordinò allora di
occupare Corfù inaugurando la tendenza all’imperialismo fascista, l’aggressione
armata di uno Stato più debole basata sul fatto che nessun altro Stato avrebbe
per questo preso parte al conflitto. L’immediata conseguenza fu l’irrigidimento
dei rapporti tra gli altri stati europei e l’Italia. Anche se l’Italia fu
costretta dalla Società delle Nazioni a
ritirarsi, quell’evento fu mostrato come un trionfo della politica estera
fascista.
Nel 1924 Mussolini ebbe il primo vero successo in
politica estera, stipulando il trattato con il governo jugoslavo il trattato
che consentì l’annessione di Fiume all’Italia. Come segno di riconoscimento
Vittorio Emanuele III lo insignì del collare dell’Annunziata, suprema
onorificenza sabauda, che lo rendeva parente del re.
Nel 1929 il ministero degli Esteri fu affidato a
Grandi, che si liberò subito dell’impronta aggressiva data da Mussolini alla
politica estera. Seppe inserire l’Italia nella discussione di tutti i problemi
internazionali e fascistizzò il ministero degli Esteri. Non soddisfatto della
sua politica che «aveva allontanato l’Italia dal binario di una politica
realistica» Mussolini lo sollevò dall’incarico.
Nel 1933 Hitler conquistò il potere, nove mesi
dopo uscì dalla Società delle Nazioni, ma l’avvicinamento italo-tedesco non fu
immediato; di fatto Mussolini temeva che la Germania potesse entrare in
concorrenza con l’Italia nei Balcani e che Hitler volesse l’annessione
dell’Austria, che avrebbe messo in pericolo il confine del Brennero. Quando nel
1934 i nazisti tentarono un colpo di stato a Vienna, Mussolini si oppose,
schierando truppe al confine e minacciando la guerra. Egli, con gli italiani
condivideva l’atavico odio per i tedeschi, accresciuto dall’anticattolicesimo e
dal mito della razza nordica propugnato dai nazisti. Hitler però si armava e
potenziava con ritmo incessante, costringendo il duce ad un avvicinamento a
Gran Bretagna e Francia. Crollava così l’esasperante e pericolosa politica
estera dei Mussolini, condotta a vuoto per dieci anni.