|
|
|
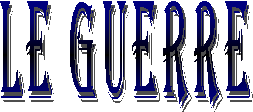
Il fascismo è passato alla storia come il regime della violenza. Dopo essere andato al potere con scontri da guerra civile e averlo mantenuto con la forza , sfociò in una serie di conflitti: la guerra d’Etiopia, la guerra di Spagna e la Seconda guerra mondiale furono l’escalation che i gerarchi, ispirati in parte dalle idee dannunziane e dall’arditismo, e in particolare Mussolini vollero e ottennero.
La guerra assunse ben presto le dimensioni di un
mito che sorreggeva il nuovo Stato: non solo perché il fascismo era violento,
ma soprattutto perché l’ultimo conflitto era ancora vivo nelle coscienze e
l’Italia ne era uscita, in teoria, unita e vincitrice. «Per questo motivo era
naturale che la volontà di giungere da una religione della patria ad una
religione del fascismo comportasse il passaggio attraverso la guerra; per tal
motivo è assurdo il luogo comune secondo il quale Mussolini sbagliò solo quando
decise di entrare nella Seconda Guerra mondiale:era una decisione inevitabile
perché faceva parte dell’essenza del fascismo-religione.» (G.B. Guerri)
Quando il fascismo ebbe toccato un alto livello
nell’organizzazione di se stesso, nel controllo dello Stato e delle persone non
trovò più in Patria alcun motivo che lo portasse ancora a dover combattere in
Italia; soltanto il faccia a faccia internazionale prometteva nuovo ossigeno.
Il fascismo voleva diventare la nuova forma di Stato del XX sec., superando il
capitalismo e soprattutto il comunismo. Da una parte c’era chi voleva ottenere
questi risultati con sistemi pacifici (Bottai e Grandi), all’interno del
partito, purtroppo, prevalse però la linea «dura», che riteneva che lo scontro
dovesse essere decisivo e frontale, linea propugnata dalla maggior parte dei gerarchi
e da Mussolini.
Nel 1934 Mussolini decise di investire in armamenti buona parte della spesa pubblica. Il ruolo del fascista come cittadino-soldato venne rafforzato, nelle scuole si istituì la cultura militare e per i lavoratori la preparazione pre e post militare. Il duce era convinto che la voglia di pace di Gran Bretagna e Francia fosse fondata sul terrore della guerra e pensava che nessuna delle due potenze avrebbe mai mosso un dito per impedirgli un’azione che non danneggiasse direttamente le loro politiche economiche. Agli occhi di Mussolini l’Etiopia era il miglior partito rimasto, l’unico stato ancora indipendente dell’Africa, ma trovò opposizioni da parte degli italiani, dei militari e del Gran Consiglio, perché tale guerra avrebbe indebolito eccessivamente l’Italia. Ma poiché l’ultima parola spettava al duce, questi prese accordi con Pierre Laval, nel gennaio del 1935. Gli accordi erano però poco chiari e nessuno parlava di azione militare: l’intervento italiano sarebbe stato piuttosto una sorta di mandato sull’Etiopia. Il governo inglese fu remissivo.
All’alba del 3 ottobre i contingenti italiani
invasero l’Etiopia senza dichiarazione di guerra, per spregio del nemico. Era
l’inizio della più anacronistica impresa coloniale dell’Occidente ma si rivelò
un gran successo per Mussolini e il fascismo. In due giorni Adigrat venne
occupata e di seguito Adua, De Bono telegrafò al duce che «un’antica onta era
lavata». La guerra fu condotta dal
generale Graziani, la cui ferocia sarà testimoniata nel 1937 quando per
rappresaglia ad un attentato fece trucidare oltre 3000 abissini. Rimosso De
Bono perché troppo indeciso, Badoglio entrò ad Addis Abeba il 5 maggio.
A parte questo “successo” però, la situazione
economica dell’Italia era peggiorata; la guerra aveva dato nuovo impulso alla
produzione, ma nel frattempo i soldi destinati ai lavori pubblici erano stati
dirottati verso l’impresa bellica riducendo l’occupazione e il tenore di vita.
La propaganda riuscì a far credere che l’impero sarebbe stato il toccasana dei
mali nazionali. Se la fine della guerra segnò il momento di massimo prestigio
per il regime, suscitò anche aspettative enormi: il fascismo adesso doveva
mantenere le promesse fatte, benessere, pace, allentamento della dittatura.
Erano promesse che però il regime non avrebbe soddisfatto: per incapacità, per
propria volontà e perché trascinato dagli eventi. Al popolo che aspettava i
benefici della guerra d’Etiopia fu risposto con un’altra guerra, quella di
Spagna in cui c’erano da difendere non già gli interessi del Paese, ma del
fascismo.
L’impresa africana aveva mutato profondamente il
panorama europeo: nel 1936 l’Italia era isolata, senza alleati. In questa
situazione Mussolini scelse il nuovo ministro degli esteri, aveva 33 anni, era
Galeazzo Ciano.
Se la guerra d’Etiopia rispondeva alle necessità del fascismo, quella di Spagna invece fu una scelta di espansione ideologica: si combatteva il comunismo e si appoggiava una dittatura di destra per far trionfare l’idea fascista. Mussolini si impegnò in un conflitto altrui, difficile e logorante, da cui credeva di uscire in pochi mesi. Fu invece la prima prova in cui l’infallibilità mussoliniana e con sé il regime subì il primo colpo.
Inizialmente il duce si rifiutò di inviare aiuti
a Franco, ma cambiò idea quando seppe che la Francia riforniva i repubblicani e
la Germania si era schierata con i franchisti. Così il 30 luglio 1936 inviò
quanto richiesto, anzi inviò più di quanto dovesse facendo sì che l’Italia fosse
la nazione più impegnata nel conflitto,
con 72.827 uomini di cui buona parte volontari. La guerra che nei progetti del duce doveva essere veloce e
indolore si trascinò invece molto lentamente. Quello che Mussolini non capiva
era che Franco non aveva nessun vantaggio a vincere in breve tempo la guerra,
trovandosi poi a governare un paese di macerie e a lui ostile; preferiva
consolidarsi nelle zone conquistate prima di attaccarne altre. Franco fu
costretto a rompere gli indugi nel marzo 1937: l’8 iniziò l’avanzata verso
Madrid, con 50.000 uomini al comando del gen. Roatta, di cui circa 2.000
vennero uccisi e 4.000 feriti durante
la controffensiva repubblicana del 18 marzo. Tale insuccesso fu
gravissimo, perché apparve come la prima sconfitta del fascismo, per di più
contro forze antifasciste. L’uso propagandistico che ne fu fatto fece capire a
Mussolini che le azioni del regime sarebbero state messe sempre di più in
discussione: si sarebbero dovute imporre con aggressività, magari appoggiandosi
ad un alleato forte e deciso. Fu così che quando nell’aprile del 1937 la
Germania bombardò Guernica, Mussolini realizzò che essa aveva quella “volontà
d’acciaio” che stava cercando e la volle uguagliare con il bombardamento su
Barcellona (16-18 marzo 1938).
La guerra, ormai vinta da Franco, si trascinò
però fino al 1939. Costò all’Italia ben 3.819 morti, oltre 11.000 feriti, un
enorme sforzo economico e la perdita di molto materiale bellico, ma la peggior
conseguenza fu che Mussolini iniziò ad avvicinarsi sempre di più alla Germania
e non potè mantenere le promesse fatte alla nazione.
L’ingenuità di Mussolini fu credere che una
nazione povera e debole come l’Italia avrebbe potuto davvero tenere sotto controllo
la ricca e fortissima nazione tedesca, guidata dal determinatissimo regime
hitleriano. Tale idea era nata in lui fin dal primo incontro con Hitler
(Venezia, 1934), quando aveva potuto trattare il Führer come un ammiratore
esaltato. Nel 1936 Ciano firmò un
accordo con il quale le due nazioni si impegnavano a tenersi informati,
consultarsi e coordinare le azioni in politica estera. Mussolini volle
pubblicizzare tale accordo e l’1 novembre pronunciò per la prima volta la
parola “asse”. Il duce voleva suscitare tensione in Europa con la pericolosità
di questa amicizia e conferire all’Italia un ruolo centrale: tutti i paesi
avrebbero dovuto accordarsi con il regime per avere garanzie di pace. Il 2
gennaio 1937 stipulò un patto con l’Inghilterra, passato alla storia come
“Gentelmen’s Agreement”: i due paesi si accordavano per mantenere lo status quo
nel Mediterraneo, a tutelare la libertà di navigazione, a non ledere gli
interessi e a migliorare i loro rapporti. Il 25 marzo Ciano firmava un accordo
di amicizia con la Jugoslavia, poi uno simile con Austria e Ungheria. A questo
punto l’Italia era in una situazione di forza e di privilegio: poteva svolgere
la politica del peso determinante, ma nel settembre 1937 Mussolini andò a
Berlino e si sbilanciò più di quanto Ciano avrebbe voluto. Il 6 novembre 1937
l’Italia entrò nel patto Anti-Comintern che già univa Germania e Giappone.
Come prima conseguenza l’Italia uscì dalla
Società delle Nazioni, l’11 dicembre. In secondo luogo l’Italia si rassegno
all’annessione dell’Austria alla Germania; l’11 marzo 1938 Hiler compì
l’Anschluss senza curarsi dell’Italia. Mussolini a questo punto si rese conto
dell’antipatia per i tedeschi che aleggiava nel popolo italiano
Il 7 aprile 1939 come risposta alle varie
annessioni tedesche (Sudeti e Boemia) l’Italia invase l’Albania, già di fatto
protettorato italiano.
L’errore più catastrofico per l’Italia venne
commesso il 27 maggio 1939 a Berlino, quando Ciano, pur malvolentieri, firmò
per espresso ordine del duce (quest’ultimo convinto di poter trarre enormi
benefici dall’alleanza con la potente Germania) il patto di alleanza con la
Germania, passato alla storia come Patto d’Acciaio. Comportava l’indiscussa
partecipazione a qualsiasi guerra che riguardasse l’alleato. A tal proposito è
fondamentale ricordare che i rapporti presentati al duce dai vertici delle
forze armate sottolineavano l’impossibilità di essere in grado di sostenere una
guerra almeno fino al ’43, dettaglio non trascurabile dal momento che
l’invasione della Polonia da parte di Hitler sembrava sempre più prossima. Le
conseguenze non si fecero attendere: l’11 agosto Ciano, incontrò Hitler e il
suo Ministro degli Esteri Ribbentrop a Salisburgo, dove gli venne detto che la
Germania stava per aggredire la Polonia; il colpo di grazia fu dato
dall’annuncio che la Germania stava per concludere un patto di non aggressione
con l’Unione Sovietica, che avrebbe messo in crisi un pilastro del regime:
l’anticomunismo.
Fu per opera di Ciano, convinto che i tedeschi
fossero dei traditori, che il duce non entrò in guerra ai primi di settembre.
Fu dopo Dunkerque che il re, i militari, i gerarchi e il popolo italiano si
convinsero che la Germania sarebbe uscita vincitrice dal conflitto e che si
stava sprecando una grossa occasione. Il 10 giugno 1940 Mussolini dichiarò
guerra a Francia e Gran Bretagna.
La guerra rivelò lo stato disastroso dell’esercito già nella campagna alpina contro la Francia e nell’attacco contro la Grecia nell’ottobre 1940. Tutto ciò era imputabile direttamente a Mussolini: aveva tenuto per sé i ministeri militari, senza averne la capacità, aveva tagliato negli anni le spese militari, non predispose la ristrutturazione industriale ed era perfettamente conscio dell’impreparazione militare italiana. La leggenda per cui i militari avrebbero ingannato il duce sul reale stato dell’esercito è appunto tale. Tutto ciò portò al rapido crollo del regime i cui ultimi pilastri caddero rovinosamente il 25 luglio 1943. Mussolini distinse, quel giorno, fra i votanti, i traditori, i complici, gli ignari; appartenevano alla prima categoria (cioè a coloro che sapevano ciò che facevano) Grandi, Bottai, Ciano; alla seconda De Vecchi e De Bono; alla terza tutte figure di secondo piano, la maggior parte delle quali partecipava per la prima volta ad una seduta del Gran Consiglio. In realtà non ci fu nessun tradimento: il Gran Consiglio era un organo consultivo e il 25 luglio espresse un parere perfettamente legittimo.
I fatti. Il 22 luglio Grandi e Bottai si
incontrarono per lavorare all’ordine del giorno che Grandi aveva già
preparato, il 23 si aggiunse anche
Ciano. Il 24 luglio, nel salone del Mappamondo, Mussolini prese per primo la
parola, tentando di portare la discussione su problemi militari. Poi presero la
parola Bottai, Grandi e Ciano. Il primo portò il discorso sul piano politico
ponendo sotto accusa «l’apparecchio di comando insufficiente». Subito dopo
Grandi ne propose la sostituzione e lesse l’ordine del giorno. Ciano elencò i
tradimenti commessi dai tedeschi verso l’Italia, contribuendo ad affossare
Mussolini di fronte ai gerarchi che compresero come si era fatto giocare da
Hitler.
Mussolini propose un intervallo, durante il quale
Grandi raccolse le firme di adesione al suo ordine del giorno; alla riapertura
le mostrò al duce, erano 19. Alle 2 di notte del 25 luglio, dopo 9 ore di
seduta Mussolini disse di procedere alla votazione dell’ ordine del giorno
Grandi: i favorevoli furono 19, i contrari 7 e un astenuto. Mussolini ancora no
si era arreso, credeva ancora nel re. Questi però decise di approfittare del
voto del Gran Consiglio. Il pomeriggio del 25 destituì Mussolini e lo fece
arrestare. La sera fu comunicato che Badoglio aveva assunto il comando
militare. Bastò una notte a dissolvere quello che ormai restava del PNF, Milizia
compresa.
Nel 1927 nacque la Concentrazione antifascista, il maggior gruppo di opposizione al regime, composta da socialisti, repubblicani e dalla Confederazione generale del lavoro. Ad emergere all’interno dell’antifascismo fu però il Partito comunista, forte della sua determinazione e dell’organizzazione con la quale aveva creato una diffusa rete clandestina in Italia. Attorno a questi nuclei nacque la Resistenza, divisa in partiti e gruppi, clan e sottogruppi che sarebbe stato difficile unificare. Solo nel 1944 i capi dell’antifascismo si fecero promotori di una nuova identità, quella partigiana, una linea comune che fu trovata con la decisione di Togliatti di allearsi con Badoglio e con gli americani. La Resistenza fu, comunque, un valore più morale e simbolico che militare e politico, perché se scarsi furono i suoi effetti militari e politici certamente ebbe il merito di opporsi al sopruso nazifascista; una strumentalizzazione ideologica ha però fatto della Resistenza un’altra religione laica nata per reazione alla decomposizione del fascismo.
Hitler non aveva affatto gradito la defenestrazione del suo vecchio amico e maestro e non credeva alle promesse di Badoglio di restare fedele all’alleanza, e non si sbagliava. In agosto cominciarono le trattative segrete di Badoglio con gli alleati per l’accordo che sarebbe stato firmato a Cassibile il 3 settembre. Il re e lo stato maggiore fuggirono al Sud abbandonando Roma al suo destino. I tedeschi, che erano preparati all’evento, disarmarono facilmente quasi tutto l’esercito italiano e occuparono due terzi dell’Italia, ripristinando subito le organizzazioni fasciste.
Il 12 settembre i tedeschi liberarono Mussolini e
lo portarono in Germania. Era stanco, sfiduciato, disilluso (durante la
prigionia aveva scritto:«Sono giunto a due conclusioni:1)il mio sistema è
disfatto;2)la mia caduta è definitiva. Il sangue mi dice che la mia stella è
tramontata per sempre»). Pur controvoglia fu costretto ad accettare di mettersi
a capo di quella parte dell’Italia (da Salerno in su) occupata dai nazisti. Sul
duce però i tedeschi contavano pochissimo, era più un immagine (Goebbles
scriveva:«Dobbiamo cominciare a fare su Mussolini, in senso politico, una
croce, non è più quello di un tempo e non si può contare su di lui, specie
perché non ha più autorità).La prima assemblea avvenne il 14 novembre 1943 e
approvò i 18 punti programmatici della RSI. Il principio fondamentale era: “Non
è il regime che ha tradito la monarchia, ma la monarchia che ha tradito il regime”;
bisognava dunque «eliminare i traditori, in particolare quelli che fino alle
21.30 del 25 luglio militavano nelle file del Partito e sono passati al
nemico».
A dar nuova vita alla RSI e al fascismo furono,
tra ‘altro, molti giovani colti da sentimenti religiosi verso la patria e il
suo profeta, a testimonianza che l’educazione fascista non era stata vana. Nel
diario di uno di questi leggiamo:«Avevo vent’anni: e pensavo che una guerra si
può anche perdere, ma bisogna perderla con onore; che non si passa da una
trincea all’altra; che non si tradiscono i morti per ingraziarsi i vivi che vincono; che non si tradisce la parola data; che non si può
dire a chi a creduto in una causa e per essa si è battuto “abbiamo scherzato,
mettiamoci da quest’altra parte”. Non era più questione di fascismo o
antifascismo, di re o Duce, ma solo questione d’Italia».
D’altro canto la sua rovina fu data dal suo far
parte dell’esercito nazista, odiato dagli italiani.
Con il processo di Verona dell’8-10 gennaio 1944
la RSI decretò la pena di morte per i «traditori»: dei 6 presenti in aula, 5
vennero fucilati l’11 gennaio (Ciano, Marinelli, De Bono, Pareschi e Gottardi)
mentre il sesto, Cianetti, ebbe la pena commutata in trent’anni perché la
mattina del 25 aveva scritto al duce ritirando il suo voto.
La fine della RSI, tuttavia, non era lontana; i
suoi provvedimenti politici e civili non riuscirono a frapporre ostacoli
ideologici fra i partigiani e il resto della popolazione. Le masse, nucleo
forte del fascismo d’un tempo, ora non rispondevano più al fascino del capo e ai richiami della religione della
patria. Così la RSI puntò tutto su un altro mito fascista: la violenza contro
il nemico. La violenza esasperata, quel bagno di sangue con cui si sarebbe
conclusa l’epopea della RSI erano una diretta conseguenza del tentativo di
ritornare alle origini del fascismo. Il 26 giugno 1944 venne istituito il corpo
delle Brigate nere, comandato dal segretario del Partito fascista Repubblicano,
Pavolini. Le Brigate vollero essere una
risposta alla violenza partigiana e rappresentare i duri e puri della RSI, ma
al loro interno si annidavano invece criminali e assassini senza credo. Fu una
sorta di ritorno miticizzato allo squadrismo.
Con la liberazione giunsero inevitabili le
vendette: si conta che alla fine dell’aprile 1945 i partigiani abbiano ucciso
tra i 12.000 e i 15.000 fascisti, ormai sconfitti.
Sugli ultimi giorni del duce c’è una letteratura sterminata, ma ha scarso interesse se a premere il grilletto sia stato questo o quello. L’unico dato veramente importante della sua morte è che gli alleati lo volevano vivo, per processarlo a Norimberga come i nazisti. Le forze partigiane invece questo processo non lo volevano, non solo per furore e voglia di giustizia, ma anche perché sapevano che Mussolini avrebbe spiegato al mondo quanto e come gli italiani avevano creduto in lui, quanto erano stati suoi complici e adoratori.