|
|
|
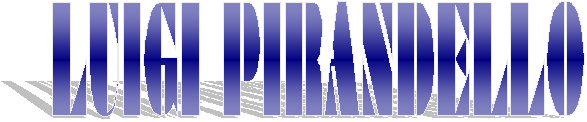
Luigi Pirandello nasce nella campagna circostante Girgenti il 28 giugno 1897.
Il padre apparteneva ad una ricca famiglia di commercianti di zolfo ed anche la madre era di famiglia benestante.
Nel
1903, però, l’allagamento delle miniere di zolfo d’Aragona nelle quali il padre
aveva impegnato tutti i propri capitali provocò il crac della famiglia e fu
proprio Luigi a tentare di risollevare le sorti della famiglia offrendo il
proprio contributo retribuito a vari giornali. Su uno di questi (La nuova
antologia) compare nel 1904 Il fu Mattia
Pascal.
Nel
1908 viene pubblicato l’importante saggio Sull’Umorismo
in cui intesse una lunga polemica con Croce.
Allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale Pirandello s’infiamma di fervore
patriottico: la guerra gli sembra poter rinverdire i fasti di quei miti
risorgimentali istillati in lui dalla madre.
Un
avvenimento molto importante si colloca nel 1924: l’adesione ufficiale al
fascismo. La sua adesione al regime non è però dettata da calcolo
utilitaristico (nel ’24 il fascismo si trova in gran crisi per il delitto
Matteotti). Nel fascismo, invece, Pirandello crede di trovare una risposta alle
sue delusioni e ai suoi miti infranti; il regime sembra inoltre poter far pulizia
di quei parlamentari corrotti e “bertuccioni” a cui opporre un movimento in
continua progressione. Nell’adesione al fascismo appare anche una spinta di
nazionalismo linguistico e letterario che si era manifestato molto presto in
Pirandello nel desiderio di un’arte italiana che non imitasse gli stranieri.
Pirandello vedeva in Mussolini l’uomo che era riuscito a dare all’Italia un
prestigio tutto suo. Non mancarono certamente in Pirandello anche spinte più
propriamente politiche: profondamente borghese, Pirandello vede protetti gli
interessi della sua classe da un regime che si oppone in maniera decisa al
socialismo.
Nel
’25 Pirandello dirige il Teatro d’Arte di Roma, ma poi, nel ’28, abbandona
l’Italia. Richiamato dal regime, lo scrittore torna in Italia nel ’34, anno in
cui gli viene conferito il premio Nobel.
Il
10 dicembre 1936 Pirandello muore a Roma.
Fin dai primi scritti Pirandello mette in luce la solitudine e l’infelicità dell’uomo contemporaneo: l’insicurezza, il moltiplicarsi delle prospettive, la mancanza di un unico punto di riferimento sono dovuti a suo avviso al fallimento della cultura positivistica e allo scacco della scienza di fronte alle domande ultime dell’uomo.
Pirandello traccia, quindi, le linee di un malessere la cui maggior colpevole è la scienza: essa ha corroso il concetto di Dio e ha assegnato all’uomo un “malinconico posto nell’universo”, frantumando quella prospettiva antropocentrica, fonte d’orgoglio e di sicurezza per l’uomo dei tempi passati.
L’uomo
pirandelliano si trova solo nel buio labirinto di una realtà problematica e
inconoscibile, in una solitudine che non promuove impennate titaniche o
superomismi, l’impegno è quello di affissare gli occhi alla realtà delle cose.
La nostra realtà interiore –dice
Pirandello- è un flusso continuo ed è sottoposta ad un continuo divenire, che
non si può conoscere, se non a patto di arrestarne innaturalmente lo scorrere.
In questo continuo cambiamento abbiamo bisogno di assumere una forma;
inconsciamente ci mascheriamo, crediamo di conoscerci, ma in realtà diamo solo
un’interpretazione del nostro essere interiore, lo dissimuliamo e ci costruiamo
in quello che crediamo di essere e non siamo. Noi non ci conosciamo e non viviamo la realtà profonda, ma una sua metafora:
ognuno infatti ci attribuirà una forma diversa e certamente non corrispondente
all’inconscia metafora che noi stessi assumiamo, né a quella che gli altri,
ciascuno a suo modo, ci attribuiscono.
La
ragione, la facoltà umana per eccellenza, è solo un triste privilegio: l’acuto
e sottile argomentare dei personaggi pirandelliani è un coltello che scava nella piaga, dal momento che la lucidità
dell’analisi promuove una forma più disperata di infelicità, non sottraendo
l’uomo al suo inferno, ma facendogli vedere l’impossibilità del riscatto.
Senza
nessuna certezza, dunque, l’uomo pirandelliano vive in bilico tra una
deformante e angusta maschera e il rischio dei una totale nullificazione.
Pirandello rifiuta la concezione dell’arte come imitazione e come specchio della realtà. La verità dell’arte non può prescindere dalla criticità del reale; la disinteressata e autentica coscienza dell’artista accoglie la realtà e ne sviluppa la potenzialità compromessa sul piano dell’esistenza.
L’umorismo sorge su di uno stato d’animo
complesso; propria della sua natura è infatti la compresenza di contrasti.
Nell’arte umoristica sussistono tendenze antitetiche che lo scrittore non si
sforza di comporre: il primo contrasto è quello tra sorriso e tristezza.
Nell’umorismo ciò che pare sorriso è dolore e viceversa. Il riso nasce dal
comico che Pirandello definisce avvertimento del contrario; il comico
scaturisce dall’accorgersi che una persona o una situazione si allontanano
dalla normalità; l’approfondimento e la riflessione, però, scompongono la
situazione comica e scorgendone le radici tragiche fanno scaturire un riso
intriso di dolore: dall’avvertimento del contrario si passa al sentimento
del contrario.
L’umorismo,
dunque, è l’arte che scompone e distrugge tutte le certezze, che coglie la
mutabilità perenne del reale e la sua problematicità.
Il
fondo idealistico della meditazione pirandelliana po’ essere questo: gli
ostacoli, le miserie, le contraddizioni della natura e della realtà trovano la
loro soluzione nell’arte; solo nell'’arte vengono eliminati gli scarti tra
potenza e atto.
L’arte
umoristica, insomma, è forma e vive per sempre.
testi
Enrico IV
|
Il turno
|